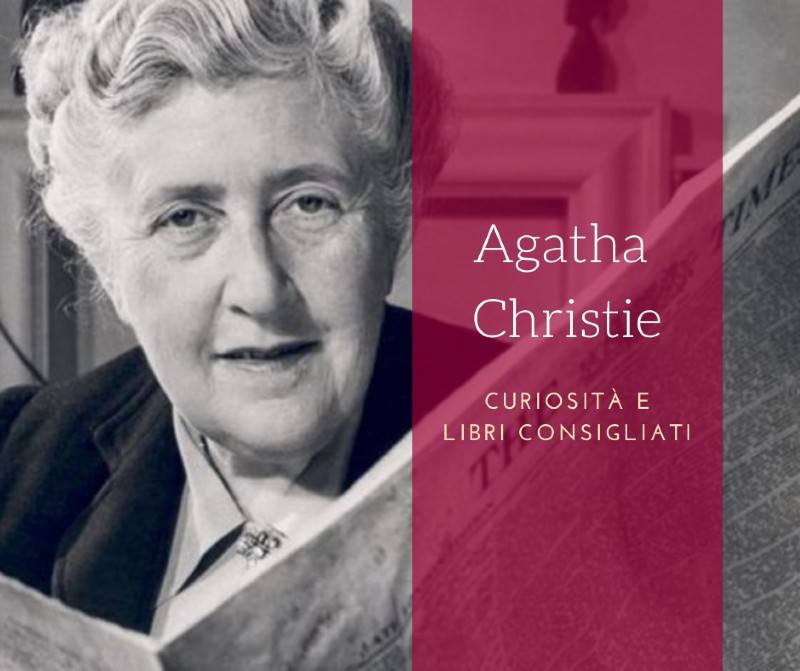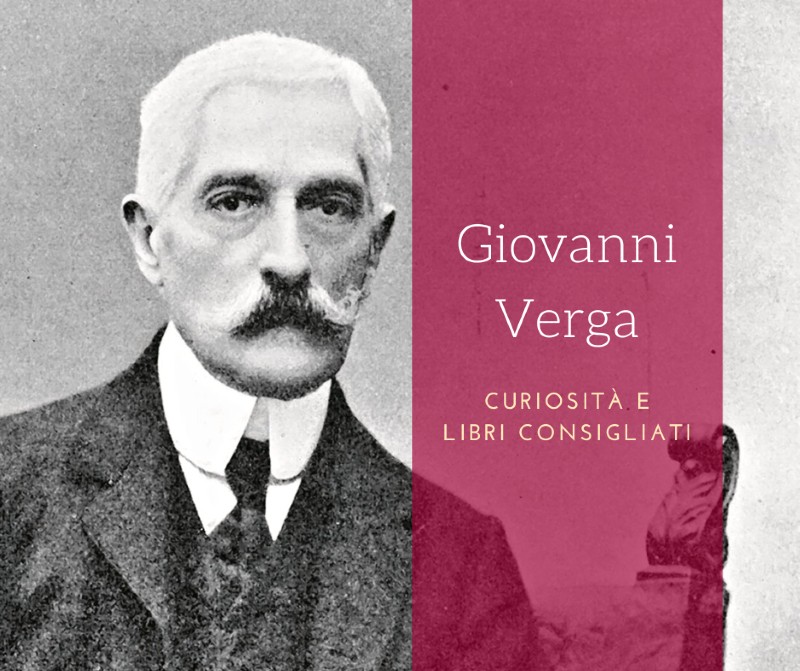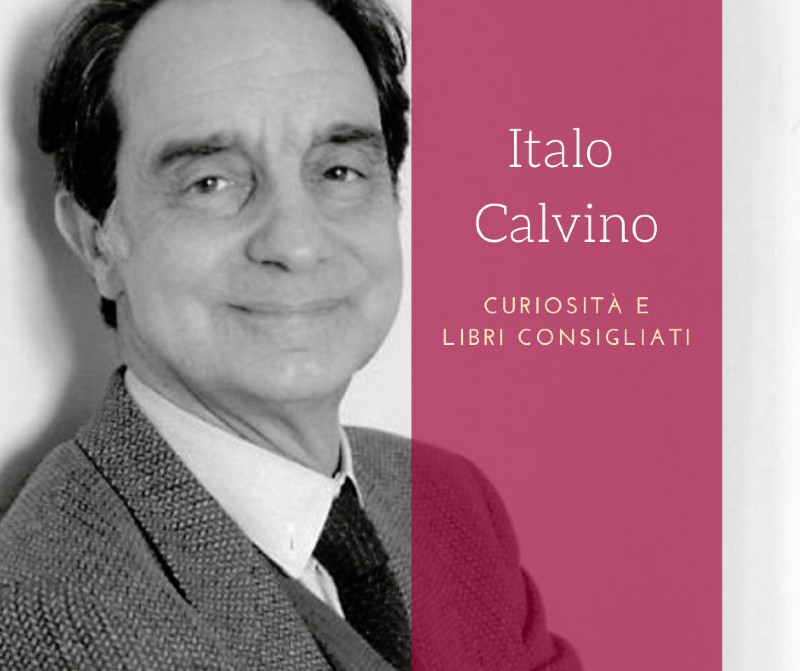Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello è l’opera italiana che segna il distacco dal romanzo dell’Ottocento. Allontanandosi dal modello narrativo verista, Pirandello inaugura lo stile umoristico, misto tra tragico e comico, che è ben delineato nel saggio L’umorismo del 1908, testo fondamentale della sua poetica.
Novellista e giornalista
Pirandello lavora ad altri romanzi e nel 1909 dà inizio alla sua lunga collaborazione con il «Corriere della sera», che si protrae, a intervalli, fino al dicembre del 1936.
Negli anni, all’attività di romanziere e drammaturgo si intreccia quella di novellista. Il corpus delle novelle pirandelliane è infatti imponente, contando 237 lavori, e si rivela essere un catalogo di casi strani, surreali, intrecci assurdi che mettono in evidenza l’imprevedibilità che si cela dietro ai più piccoli eventi della quotidianità.
La vita privata di Pirandello
Dal punto di vista personale, il periodo della Prima Guerra mondiale fu per Pirandello un periodo tragico. Muore nell’agosto del 1915 la sua amata madre, Caterina. Il figlio Fausto va sotto le armi e il figlio Stefano, partito come volontario, viene fatto prigioniero e liberato soltanto al termine del conflitto. Durante la prigionia intrattiene con il padre un intenso rapporto epistolare. Nello stesso periodo si aggravano le condizioni della moglie Maria Antonietta, tanto che nel 1919 Luigi Pirandello, sotto consiglio dei medici, è costretto ad internarla in una casa di cura di Roma, a causa dell’ossessione patologica di questa nei confronti del marito. Maria rimane nella clinica fino alla morte, avvenuta nel 1959.
Il teatro di Pirandello
A dispetto dei problemi personali, Pirandello continua a lavorare ininterrottamente. Il vero grande amore dell’autore siciliano è il teatro che, grazie a lui, trova nuova linfa. I primi lavori teatrali di Pirandello risentono molto del verismo regionale, basta pensare a L’epilogo, del 1898, o a Liolà, del 1916. Ma è nel 1917, con la commedia Così è (se vi pare) che l’autore porta in scena, per la prima volta, i princìpi del relativismo pirandelliano: la realtà viene percepita da ciascuno in maniera diversa.
Il dramma che, però, rivoluziona il modo di fare teatro è Sei personaggi in cerca d’autore (il dramma si presenta senza divisione in atti), che va in scena la prima volta al Teatro Valle di Roma il 9 maggio 1921, portando a casa un grande insuccesso, ma trionfa successivamente nei teatri milanesi. Sulla stessa linea Ciascuno a suo modo (1924) e Questa sera si recita a soggetto ( 1930).
La rivoluzione teatrale di Pirandello
Questi tre drammi sono rivoluzionari perché con essi Pirandello denuncia l’inadeguatezza dell’impianto teatrale tradizionale, non più riproducendo la realtà, ma introducendo realmente la vita sulla scena attraverso il «teatro nel teatro». Pirandello smaschera il teatro come simulazione della vita, abbattendo tutte le possibili divisioni tra realtà e finzione.
Il drammaturgo rinnova il teatro nei contenuti e nelle tecniche narrative. Questi drammi e il successivo Enrico IV consegnano Pirandello al successo nazionale e internazionale.
Nel 1923 inizia, infatti, la stagione dei suoi viaggi in Europa e America. Le sue opere vengono portate anche sui palchi di Broadway, consacrandone la fama.
Il Partito Fascista e la relazione con Marta Abba
Nel 1924, Pirandello si iscrive ufficialmente al Partito Fascista e l’anno successivo, avendo ormai lasciato l’insegnamento, assume la direzione artistica del Teatro d’Arte di Roma. Nello stesso anno, inizia il rapporto con la giovane attrice milanese Marta Abba, di cui Pirandello intuisce subito il talento. Da quel momento, Marta diventa la prima donna della Compagnia del Teatro d’Arte e anche compagna e musa del famoso autore.
Uno, nessuno, centomila
Il 1926 è l’anno di un dei romanzi più noti dell’autore: Uno, nessuno, centomila. Uscito in volume a Firenze, per Bemporad, questo romanzo, ha avuto una gestazione di ben quindici anni. È questo il testo che più di ogni altro rivela la poetica dell’umorismo di Pirandello, la frantumazione della personalità, le maschere indossate da tutti gli appartenenti alla società.
Un testo importante per la letteratura italiana del Novecento, e non solo.
Dopo questi grandi successi e la fama ormai raggiunta, si sposta, per un periodo a Berlino. Qui lavora ad alcuni progetti cinematografici e presenta la prima, a Koenigsberg, di Questa sera si recita a soggetto, dramma che non riceve il consenso sperato. Terminata l’esperienza in Germania, torna in Italia, dove continua a lavorare senza sosta.
Riconoscimenti e scomparsa
In questi ultimi anni riceve alcuni importantissimi riconoscimenti: nel 1929 viene nominato Accademico d’Italia e nel 1934 è insignito del Premio Nobel per la letteratura.
Muore il 10 dicembre 1936 a Roma. Secondo le sue volontà fu cremato e il funerale si svolse in totale povertà, senza alcun accompagnamento. Le sue ceneri, dopo più spostamenti, sono ora tumulate ad Agrigento, sotto il pino della Villa del Caos. Nel 1949 la Villa è stata dichiarata monumento nazionale.